Che l’inglese che studiamo a scuola non sia esattamente rappresentativo delle molte vesti di questa lingua lo scopriamo facilmente quando viaggiamo: per fare un esempio del tutto a caso, magari atterriamo all’aeroporto di Glasgow in Scozia, scambiamo due parole con una persona del posto sentendoci moderately confident e pensiamo, ecco, lo sapevo, ho sbagliato volo e sono finita alle isole Svalbard. (Ero poco più che ventenne e non ero stata molto spesso in paesi anglofoni: a pensarci bene, l’unico contatto serio era stato quello con l’Irlanda, l’adorata Irlanda, prima dalle parti di Dublino e poi sulla costa atlantica. Avevo preso nota dei vari accenti irlandesi, ma non mi erano mai risultati incomprensibili.) È da un po’ che mi chiedo perché nello studio delle lingue straniere si tralasci spesso, almeno nella mia esperienza con inglese e tedesco, di far confrontare studenti e studentesse con un aspetto fondamentale: c’è la lingua asettica che si studia in classe o in aula, e poi ci sono le sue incarnazioni parlate per le strade e scritte nelle chat. Capisco che per rigirarsi in una lingua la si voglia far conoscere prima attraverso una sua veste standard, per così dire, per non affrontare troppo presto sfumature e casi particolari. Però un contatto di qualche tipo con varianti e dialetti sarebbe illuminante, a mio avviso. Forse questo accade già e sono io che non sono aggiornata: i miei ricordi dei corsi di inglese sono datati, ma con il tedesco ho fatto esperienze più recenti e niente, confermo che era il tedesco vagamente irreale di Amburgo.
In un bellissimo articolo del New Yorker segnalato quell’occhio di lince che è
, sono capitata su un passaggio che era più una digressione che altro. Per me invece è stato l’impulso che mi ha spinta a soffermarmi meglio sulla questione delle molte forme dell’inglese. Il passaggio è questo:[English] is far less unitary than we often suppose. The version of English that the B.J.P. [Bharatiya Janata Party] seeks to weaken differs considerably from whatever the British first imposed some two centuries ago. It’s a language enamored with the progressive tense (as in “I am going to school every day”), (…) and in which “Kindly do the needful and prepone our meeting to tomorrow itself, na?” is a typical request. (…) After centuries spent fermenting in the subcontinent, English has turned Indian.
L’immagine di un inglese che “fermenta” e “diventa indiano” mi è piaciuta tantissimo. Grazie a questo spunto e agli esempi citati nell’articolo ho preso coscienza di quanto sia multiforme la risposta alla domanda: quante vesti ha l’inglese?
La ricerca
Allora, queste vesti dell’inglese, quante sono? La risposta breve è, tante. I luoghi dove si trovano dialetti dell’inglese sono molti: Irlanda, Scozia, Australia, Nuova Zelanda, … La lista è lunga. Volendo allargare un po’ gli orizzonti, potremmo poi considerare i cosiddetti English-based creole languages, ossia le lingue derivate dalla combinazione di una lingua africana o asiatica, per esempio, e dell’inglese. (La creolizzazione delle lingue è un fenomeno che non riguarda solo l’inglese. Ho fatto poche ricerche e trovato risorse vecchiotte al riguardo, per cui aggiungo che non sono sicura che il termine ‘lingua creola‘ sia il più appropriato al giorno d’oggi.)
Per dire, mai sentito parlare del Singlish? In questo articolo del Guardian ho scoperto che si tratta del Colloquial Singaporean English, una lingua creola dove buona parte del vocabolario è presa dall’inglese ma alcune parole provengono da lingue come il Malay e il Tamil. Le strutture grammaticali possono essere molto lontane da quelle dell’inglese studiato a scuola, in parte perché seguono l’esempio di lingue come il cinese mandarino. È anche per questa ragione che può risultare difficile da capire: l’articolo del New Yorker lo descrive come “a creole that nonlocal English speakers struggle to follow”.
Su questo sito ho trovato qualche esempio di lingue creole basate sull’inglese. Mi sembra che la pagina sia abbastanza ben fatta, e questo commento chiarisce un punto molto importante:
Creole languages are not simply “broken English” but fully developed linguistic systems with their own rules, structures, and identities.
Tornando brevemente ai dialetti inglesi, la mia esperienza personale è limitata all’inglese di Scozia e Irlanda. A Dublino ho scoperto “What’s the craic?”, dove “craic” è pronunciato più o meno come “crack” – però no, non vuol dire che vi stanno chiedendo dov’è la rottura (o la droga), vogliono sapere come vanno le cose. Ho letto che nel diciottesimo secolo il poeta scozzese Robert Burns usava già questa parola. A parte alcuni vocaboli che possono essere diversi, spesso è la pronuncia a confondere chi proprio non si aspetta di capire tre parole su dieci pur trovandosi in un luogo dove in teoria si parla inglese: anni fa è successo a me a Glasgow, e di recente alla mia amica Elisabetta (ciao Betta!) in Nuova Zelanda. Per farmi capire lo shock, Elisabetta mi ha detto che in aeroporto il “check-in desk” suonava più come il “chicken desk”. There you go.

Ai dialetti dell’inglese mi verrebbe voglia di affiancare una categoria che chiamerei “inglese di casa per chi comunica in questa lingua con persone care anche se nessuno di loro è madrelingua”. Se non lo uso per lavoro, il mio inglese rientra in questa categoria perché non vivo più in Inghilterra da sei anni eppure continuo a usarlo con il mio compagno, tedesco di nascita, in quello che ormai credo sia un sotto-sotto-sotto-sotto-ceppo della lingua della Regina Elisabetta II (scusate, ma io a Re Carlo III proprio non mi abituo). Questa forma dell’inglese è ormai una ramificazione tutta nostra non solo perché non viviamo più in un paese anglofono: lo è anche perché nessuno di noi è madrelingua, e soprattutto lo è perché ogni famiglia ha il suo lessico famigliare, appunto. Il nostro ha l’inglese come base e ampie contaminazioni italiane e tedesche a farcire il tutto. A questo cocktail si aggiungono poi termini ed espressioni imparati in quel fazzoletto di Inghilterra dove ci siamo conosciuti, così come citazioni varie ed eventuali di film, opere teatrali e canzoni che amiamo entrambi. Se ci pensate bene, questa è una categoria incredibilmente ricca e popolosa (e non vale solo per l’inglese, of course). Quante varianti familiari esisteranno, nel mondo, di una data lingua nazionale? È un’immagine che dà un po’ le vertigini, ma in senso buono: mi affascina pensare a quanto le lingue rispecchino noi, con i nostri vezzi e le nostre abitudini, e i nostri sguardi sul mondo.
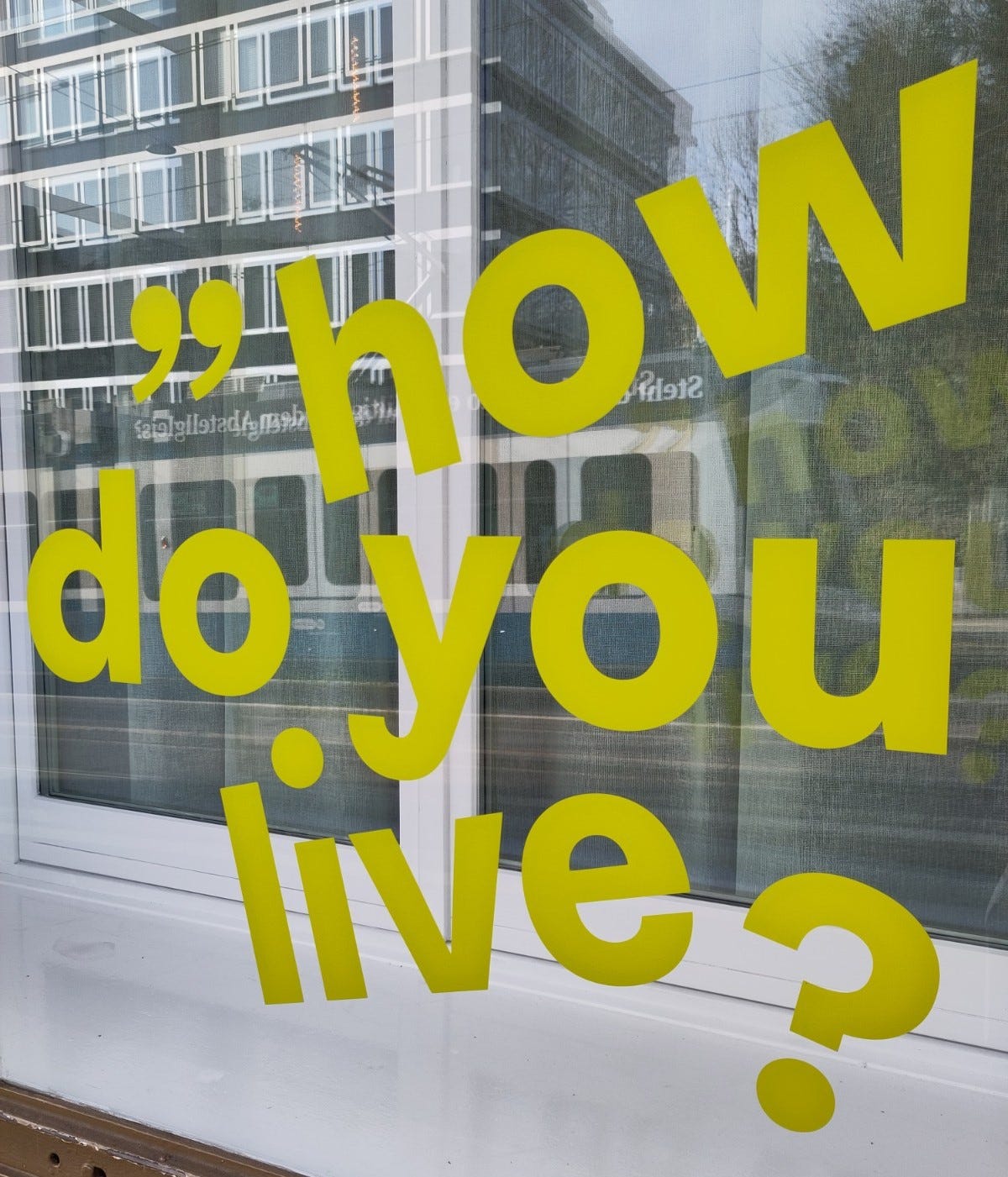
La chiave di volta
Mentre pensavo alle battute di un film e i versi di una canzone che diventano ‘di casa’, mi è tornata in mente un’osservazione linguistico-sociologica fatta sui tram di Zurigo. Lavorando in ambiente universitario, prendo spesso mezzi pubblici dove l’età media è decisamente più bassa della mia. Capto ben poco delle conversazioni dei miei compagni di tragitto perché parlano svizzero tedesco, ma capita abbastanza spesso che chi parla infili uno spezzone di frase in inglese, magari una cosa breve tipo “It’s crazy” o “Not my problem”. Sono frasi semplici, ma perché dirle in inglese se tutti i presenti parlano la lingua del posto? Forse perché l’inglese a volte permette di dire una cosa con la metà delle parole? Forse perché, a forza di vedere serie, film e video in inglese, alcune frasi diventano più spontanee in inglese? Le prime volte non ho dato molta importanza a questa osservazione, ma quando si è ripetuta nel tempo ho iniziato a farci caso. E dato che non ho notato lo stesso fenomeno in altre fasce di età, mi viene da pensare a una questione generazionale – e magari sbaglio.
D’altra parte, è difficile restare completamente isolati dall’inglese: se non sono i film sono le pubblicità per strada, le scritte sulle magliette, eccetera. L’inglese viaggia, cambia forma, si adatta. È la lingua franca della comunicazione orale e scritta in molti contesti, professionali e non, e questo suo status di ‘carta jolly’ suscita reazioni anche estreme: c’è chi la considera una lingua democratizzante proprio perché può aprire tante porte a chiunque decida di impararla, e c’è chi vede la sua quasi onnipresenza come un pericolo per il multilinguismo e le tante lingue che non riescono a essere, o se non altro a sembrare, altrettanto cool. Poi certo, proprio alla luce delle tante forme dell’inglese si potrebbe fare l’avvocato del diavolo e dire: ma quale forma dell’inglese sarebbe la lingua franca di cui parli? La dominazione dell’inglese è un mito, visto quanto è plasmabile e rimodellata questa lingua. Eh, risponderei io, insomma – I think it’s a little more complicated.
Eccoci, non si sa come ma dalla domanda gioviale e sbarazzina all’inizio di questa newsletter siamo arrivati al tema ampiamente dibattuto della dominazione linguistica (riconosciuta o presunta) dell’inglese e degli effetti che questo stato delle cose ha e potrebbe avere al livello culturale e sociale. Sempre grazie all’articolo del New Yorker, ho scovato il resoconto di una discussione avvenuta nel 1998 a Parigi tra Abram De Swaan, Pierre Bourdieu, Claude Hagège, Marc Fumaroli e Immanuel Wallerstein. Per capirci: De Swann è un sociologo così come lo erano Bourdieu e Wallerstein, Hagège è un linguista e Fumaroli ero uno storico. Si riunirono quasi trent’anni fa per farsi quella che all’epoca era (e forse è ancora oggi) una domanda di assoluta attualità: quali saranno le lingue di questa Comunità europea che va costruendosi? In effetti, vale la pena di leggere questo resoconto anche in quanto documento storico: col senno del poi, credo che tutti e quattro gli oratori sarebbero rimasti sorpresi dagli eventi susseguenti – e forse quelli sufficientemente longevi si sono stupiti. Di seguito cerco di condensare questo resoconto, e lo faccio in maniera volutamente teatrale nel tentativo di non esasperarvi del tutto.
De Swaan [apre le danze con una certa solennità]: Insomma, qui ci vuole una democrazia europea partecipativa, e per partecipare e usufruire di uno spazio pubblico europeo bisogna mettersi d’accordo sulle lingue di questa comunità – eppure regna l’indecisione!
Fumaroli [sembra di cattivo umore, forse rimpiange di aver accettato questo invito]: Sono d’accordo, però non raccontiamoci storie. L’Europa dovrebbe preservare le sue tante lingue, invece la battaglia comunicativa è stata persa e l’inglese è diventato la lingua franca.
Bourdieu [si guarda intorno e si direbbe che pensi, li vedo un po’ confusi, cerchiamo di fare chiarezza]: E va bene, l’inglese si è imposto come lingua di comunicazione privilegiata. Dobbiamo però evitare due errori grossolani: da un lato è sbagliato gettare la spugna e adattarsi a questo dominio linguistico dell’inglese. Dall’altro lato, guai a cercare di farsi paladini della francofonia a tutti i costi – we’re only going to piss off everyone. [NdR: No, non lo dice in inglese.]
Wallerstein [è statunitense, forse sente che deve portare speranza]: Ma no, che dite, l’inglese perderà terreno nel ventunesimo secolo perché le altre lingue tra cui quelle europee riguadagneranno terreno a seguito della seconda guerra mondiale. La dominazione della lingua inglese è una questione transitoria. [NdR: Ecco, dicevamo del senno del poi…]
De Swaan [interviene di nuovo, e parla come se Wallerstein non avesse aperto bocca]: Qui tocca scegliere una lingua per i cittadini europei, perché il multilinguismo è bello ma non tutti se lo possono permettere – l’inglese è qui, pronto e già studiato da tanti. E poi, se i cittadini europei si appropriano dell’inglese lo ‘europeizzano’ e il rischio di egemonia dell’inglese viene scongiurato!
Hagège [è stato zitto per tutto questo tempo ma ora non ce la fa più]: Sì, tu continua a sogna’! Il punto è un altro, il punto è rimettere in questione il fatto stesso che l’inglese sia dominante. E tu, De Swaan, fai un discorso pericoloso e non realistico.
Chissà che cosa hanno fatto i quattro oratori dopo questa discussione. Spero per loro che siano andati a bere un bicchiere di vino.

A questo punto credo di avervi persi tutti, ma nel caso siate ancora qui… permettemi di darvi il colpo di grazia. Non resisto e riporto qualche altro commento di Hagège, De Swaan e Bourdieu, perché in ognuno ho trovato spunti di riflessione stimolanti. (Occhio: il resoconto è scritto in francese e le traduzioni italiane sono tutte mie, errori compresi.)
Hagège dice molte cose sagge, soprattutto questa:
Dirò che l’avvenire dell’Europa risiede nell’educazione multilingue a scuola e non altrove. (…) Insegnare tante lingue ai bambini europei è il modo migliore di equilibrare la dominazione dell’inglese.
Come non dargli ragione? Io sottoscrivo.
De Swaan, nel chiudere la discussione, fa un’osservazione – questa sì – profetica:
C’è una politica linguistica [in Europa] che è del tutto unanime e ha un solo principio che consiste nel dire: non parliamo mai di politica linguistica. A che situazione si arriva con questa non-politica linguistica, con questa non-decisione? Ho l’impressione che si arriverà comunque alla diffusione dell’inglese come lingua veicolare primaria dell’Europa.
Bourdieu, dal canto suo, a un certo punto fa una digressione che in realtà tocca una nota fondamentale:
Ciò detto, parliamo dell’inglese in quanto lingua, ma dietro all’inglese c’è chiaramente qualcos’altro, e questo altro è il sistema statunitense. L’inglese non è la lingua dell’Inghilterra ma dell’impero economico e culturale statunitense. Quindi non si può porre il problema dell’egemonia della lingua inglese senza porre il problema dell’egemonia statunitense. (…) Quando si parla di lingue, per dirla con parole semplici, si parla sempre anche di altro.
Secondo Bourdieu, ogni strumento di comunicazione può diventare uno strumento di potere, e uno strumento di comunicazione quale può esserlo una lingua non è solo un mezzo di espressione della realtà: è anche uno strumento di costruzione della realtà sociale. A dirla tutta non credo che quest’ultimo punto, cruciale per Bourdieu, sia universalmente riconosciuto da linguisti e sociologi: l’articolo del New Yorker parla proprio di questo argomento, ossia di quanto e come le lingue influenzino le strutture di pensiero, e chiarisce che la risposta è complessa e sfaccettata. Per me, tuttavia, la prospettiva di Bourdieu è decisamente interessante perché mi riporta alle osservazioni linguistico-sociologiche fai-da-te sui mezzi pubblici zurighesi. Bourdieu ci mette una pulce nell’orecchio: se si accetta un uso così dominante dell’inglese, non è che finisce che anche i pensieri si anglicizzano in una sorta di lavaggio del cervello linguistico? (Questa è una parafrasi di un altro passaggio del suo intervento.) È sopra le righe, ma è una domanda di cui mi sono ricordata quando, qualche giorno fa, ho sentito un’altra conversazione in svizzero tedesco con frasi sparse in inglese: non è che la battuta occasionale in inglese è un modo, tutto sommato leggero ma non privo di peso, di sentirsi cool come il tale personaggio di quella serie o di quel libro che è tanto piaciuto? Chissà. Thanks a lot for reading, folks.






Bellissima la metafora della lingua che "fermenta" e diventa qualcosa di nuovo e ancor più sfaccettato. E sì, l'idea che possano esistere così tanti inglesi - partendo da quello che si parla in casa - fa un po' girare la testa ma che pluralità meravigliosa e confortante 🤩
È incredibile come proprio ieri riflettevo sulle stesse questioni di cui parli in quest'articolo. È come se tu mi abbia tolto le parole di bocca.
Dovremmo proprio partire dalla "lingua di casa" quando insegnamo una qualsiasi lingua straniera. I ragazzi amerebbero molto di più immergersi nella lingua vera, la lezione dovrebbe come una cena o un pranzo insieme a degli sconosciuti. E sarebbe bellissima questa condivisione!
Grazie 😊