Voi avete una parola preferita? Io sì, e so anche esattamente da quando: dal primo marzo 2020, giorno in cui sono andata a vedere una mostra (poco prima che anche il Cantone di Zurigo prendesse provvedimenti per arginare la diffusione del COVID-19) sulla gestione delle valanghe in Svizzera, un paese dove in alcune zone la neve è di casa e il pericolo di slavine è concreto. (Ma che differenza c’è tra valanga e slavina? Secondo il Post non c’è.) Visitando la mostra ho scoperto la parola tedesca Schutzwald, che da quel momento è diventata la mia parola preferita in assoluto. Come capita spesso in tedesco, è composta a partire da due sostantivi esistenti: der Schutz vuol dire la protezione, der Wald è la foresta. Nel contesto della gestione delle valanghe, la Schutzwald indica una foresta o un bosco che, trovandosi sulle pendici di montagne innevate, ferma o comunque rallenta un’eventuale furia bianca nel suo percorso verso i centri abitati nelle valli.
Ero arrivata in Svizzera dalla Gran Bretagna alla fine del 2019: Zurigo mi era piaciuta subito ed ero felice del cambio d’aria, ma ero ancora in fase di ambientamento. L’immagine, il concetto di Schutzwald mi ha accompagnata nel mio processo di acclimatamento, e insieme ad altri piccoli incontri fortuiti (linguistici e non) ha aperto i miei orizzonti e nutrito la mia immaginazione. In alcuni momenti, quando mi serviva, la Schutzwald mi ha fatto sentire un po’ meno spaesata.
Un primo riverbero della Schutzwald sulla mia quotidianità svizzera è stato un rinnovato slancio di amore per il tedesco, una lingua che mi ha sempre affascinata ma con cui ho tuttora un rapporto difficile. Quando parlo tedesco sento invariabilmente una mancanza di precisione e di sfumature che invece mi posso permettere nelle altre lingue che conosco; a volte mi pare che quella frase più ardita sia lì, proprio lì, la intravedo e poi niente, mi sfugge e io resto impantanata in quei venti vocaboli e cinque verbi a cui mi aggrappo come a un salvagente. La Schutzwald mi ha ricordato, guarda che lingua incredibile è il tedesco! Mi sono detta (e ripetuta nei momenti di sconforto maggiore), una lingua con parole tanto belle non può essermi ostile, riuscirò a non essere più intimorita dalla sua complessità.
Scoprire la Schutzwald mi ha anche aiutata ad aggiungere una dimensione alla mia reazione base di fronte a qualsiasi paesaggio montuoso invernale: mamma quanto so’ alte ‘ste montagne, mamma che freddo, nun me ce fate avvicina’ (sono pur sempre di Roma). Sarà che non so sciare, ma per me la montagna è un ambiente fondamentalmente ostile, quasi alieno; negli anni poi mi sono convinta che una buona fetta di turismo invernale sia una follia di massa, una vera forzatura. La Schutzwald mi ha fatto vedere, non è vero che la convivenza con la montagna è un assurdo, esistono forme di equilibrio! E succede che l’essere umano riconosca a una popolazione alberata un potere di protezione tanto prezioso da essere considerato sacro.

La ricerca
Nel tempo ho scoperto che la Svizzera ha una lunga storia di gestione delle sue aree boschive. In effetti, va detto che non tutte le foreste di protezione si sono formate naturalmente. Un aspetto che mi ha molto affascinata è stato leggere di come l’intenso rapporto tra svizzeri e foreste si rifletta ancora oggi nei nomi di alcuni luoghi, ossia nei toponimi locali.
Come spiega questo articolo pubblicato sul sito del Landesmuseum di Zurigo, un terzo della superficie odierna della Svizzera è coperto da foreste. Nel settimo secolo, quando gli alemanni si insediarono nell’attuale Svizzera germanofona, la quasi totalità del paese era boschiva. Nei secoli si susseguirono varie fasi di deforestazione: che cosa sappiamo di questi interventi sul territorio? I nomi di alcuni luoghi ne conservano delle tracce. Per esempio, si pensa che il toponimo Schwendi venga da un metodo di deforestazione che in tedesco è noto come Schwenden: a descriverlo mi sento male, perché consiste nel rimuovere una striscia di corteccia intorno al tronco dell’albero per fare sì che la pianta si secchi e muoia. In altri casi si ricorreva al debbio, ossia all’approccio cosiddetto taglia-e-brucia: non a caso esistono ancora località che si chiamano Brand e Sangi, nomi rispettivamente collegati ai verbi tedeschi brennen, bruciare, e sengen, bruciare lievemente.
Deforestazioni a parte, si direbbe che la Svizzera creda ancora nell’importanza delle aree boschive. Alcune foreste vergine sono sopravvissute fino ai nostri giorni, come quella di Derborence nel Cantone Vallese; altri boschi sono stati creati in tempi recenti, e molte foreste forniscono legna anche per scopi commerciali. In tedesco esistono sostantivi che chiariscono lo scopo (da un punto di vista, ehm, umano) di una data area boschiva: la Heuwald è una foresta dove si raccolgono foglie e paglia, mentre la Weidwald e la Stelliwald fanno da riparo per il bestiame – e poi c’è la Schutzwald, ovviamente, che protegge paesi e villaggi da valanghe e frane. Bannwald è un termine generico per indicare una foresta a uso ristretto, spesso ristretto proprio per preservarla e lasciarle compiere anche la sua funzione di salvaguardia.
Insomma, la Schutzwald è una foresta che protegge e al tempo stesso è protetta. Una bella simmetria, no?

La chiave di volta
In questo articolo, la scrittrice e giornalista Sara Rossi Guidicelli ci porta nelle foreste del Ticino:
Le prime testimonianze scritte di boschi protetti nel Cantone Ticino risalgono al tredicesimo secolo, negli statuti di Brissago con il termine di fabula iurata e negli stessi anni iniziano i decreti anche in tutti gli altri cantoni alpini della Svizzera.
In Ticino si sono dati vari nomi, soprattutto dopo che le regolamentazioni sono diventate scritte e precise. faura è il nome più bello: viene da fabula, che in latino significa parola, e per estensione patto, norma, divieto. Uno dei decreti ufficiali più severi e articolati che ci sono stati tramandati è quello della faura sopra Airolo, risalente al Settecento. Visto che il bosco era ciò che di più prezioso le popolazioni dei villaggi avevano in quei tempi, la legge per antonomasia era quella che regolava il rapporto tra uomo e bosco.
In tedesco, Schutzwald; in italiano del Ticino, faura. Ma è fàura o faùra? Nel secondo caso sarebbe immediata l’associazione con la parola paura, come osserva il poeta e traduttore Vanni Bianconi sulla rivista Specimen. Non temete, l’accento cade sulla prima vocale e quindi è fàura. Scrive Bianconi:
[La] fàura è a sua volta un luogo di confine, dove mondi diversi si incontrano. “Vei sü na creatüra pa la fàura”, “Vess sü par la fàura” vuol dire essere incinte, una creatura creata e creatrice.
Bianconi, che una faura ce l’ha dietro casa sua ad Ambrì, un piccolo paese vicino al Gottardo, ha un rapporto speciale con questa parola. Per lui la faura non è una semplice parola e non è solo un luogo. Bianconi ne osserva il riverbero di significati in un modo che mi risulta familiare perché è quello che succede quando un punto sulla mappa diventa parte della nostra geografia personale. I luoghi delle nostre vite sono ciò che noi ne facciamo attraverso le storie che ci raccontiamo e che raccontiamo.
Questo discorso mi fa tornare a una domanda che mi sono posta tante volte: quand’è che una città, un quartiere diventa ‘casa’ o qualcosa di simile a ‘casa’ (intesa come estensione della casa in cui viviamo)? Sono sicura che non c’è una risposta univoca, ma io mi azzardo a dire che la trasformazione avviene quando iniziamo a dare dei nomi ai luoghi della nostra quotidianità – e per nomi intendo i nostri nomi, non per forza quelli ufficiali. Alcuni di questi nomi possono essere del tutto personali, infatti, perché legati alle nostre esperienze, alle abitudini (che ci fanno sentire a casa), a dei ricordi importanti. In altri casi sono nomi condivisi che possono assumere quasi un sapore di affermazione collettiva di appartenenza. Per me, come per una buona fetta di romani e romane, piazza della Repubblica a Roma è piazza Esedra e forse sempre lo sarà. Il Palazzo di Giustizia suona meglio se lo chiami il Palazzaccio, anche perché se ci pensi che è così che lo chiama(va)no i tuoi genitori. E quel ponte stretto e corto vicino alla Sinagoga è il Ponte Inglese, perché i suoi versi di circolazione sono scambiati e attraversandolo in auto sembra di essere finiti in Gran Bretagna.
La questione del sentirsi a casa è una matassa con cui giocherello da anni, e so bene che non posso esaurire l’argomento in poche righe. So anche di essere in ottima compagnia: mi farebbe davvero piacere sentire altre voci, altri punti di vista, per cui scegliete voi il canale che preferite, una mail o un commento su Substack, e ditemi la vostra. Spero che questa newsletter offra spunti di riflessione validi.
Paltò potrebbe interessare ad altri. Lo facciamo viaggiare?
Leggendo Fifty Sounds, un saggio della traduttrice Polly Barton sul suo rapporto con la lingua giapponese (trovato grazie alla newsletter
– thanks Malwina!), mi ha colpita questo passaggio, forse perché stavo già lavorando alla newsletter:Language is something we learn with our bodies, and through our body of experiences; where semantics are umbilically tied to somatics, where our experiences and our feelings form a memory palace; where words are linked to particular occasions, particular senses, which gradually fade the more practised we become but remain there nonetheless in memory (…).
Barton dice che impariamo le lingue con i nostri corpi, e che le parole sono legate a determinate occasioni e stimoli sensoriali. Credo che Barton abbia colto nel segno, e penso che a volte l’apprendimento di una lingua nuova risulti difficile proprio perché lo si rende artificialmente astratto, disgiunto dal corpo e dallo spazio.
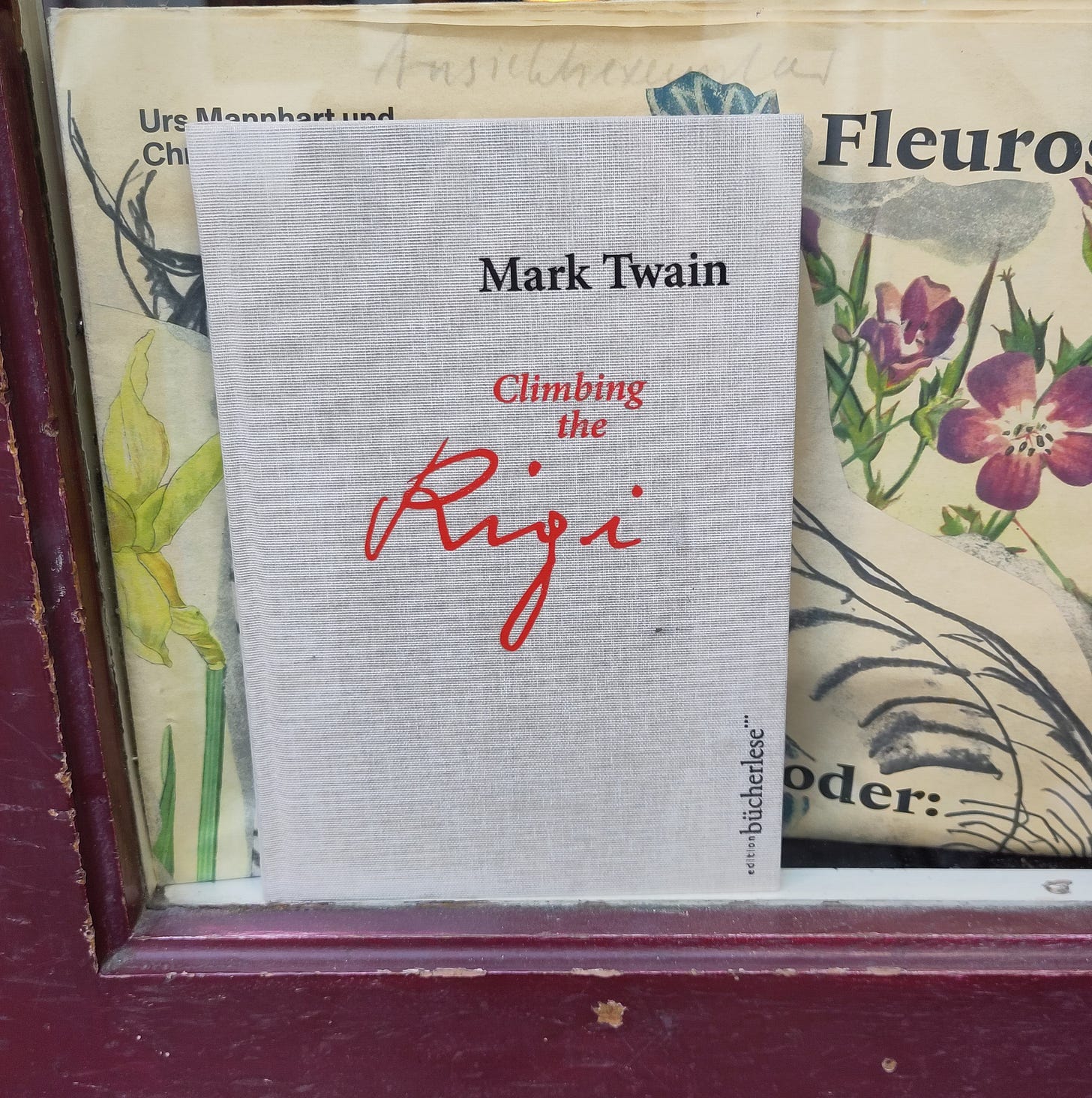
Curiosità
Proprio perché i toponimi possono rivelare molto della storia e della cultura di un paese, la loro cancellazione a seguito di un processo di colonizzazione o assimilazione culturale è una perdita enorme. Quando vivevo in Inghilterra, andai con delle amiche a vedere l’opera teatrale Translations del drammaturgo irlandese Brian Friel. La storia è ambientata intorno al 1830 nella contea del Donegal, in Irlanda del Nord, dove arrivano degli inglesi con il compito di mappare la zona per il celebrato Ordnance Survey, l'ente pubblico britannico che si occupa della cartografia nazionale. La comparsa di questi stranieri non preoccupa i locali solo perché è segnale di un crescente interesse dell’Inghilterra nei confronti dei luoghi che chiamano casa; per creare una cartografia inglese di territori irlandesi è richiesto un confronto tra lingue che necessita un processo di traduzione, come dice il titolo dell’opera, il cui esito dipende tuttavia anche da quanta disponibilità c’è a capirsi e a rispettarsi. Come rendere i toponimi gaelici in inglese? Traducendoli letteralmente o foneticamente? Che cosa si perde in questo processo, e chi si preoccupa di quello che va perso nella traduzione? Non so quanto sia facile trovare una rappresentazione di questa opera, ma se vi capita ve la consiglio vivamente.
Letture sperimentali
Vi segnalo altre due fonti che hanno contribuito alle mie riflessioni sulle connessioni tra lingue e luoghi:
“Ein Tisch ist ein Tisch”, racconto di Peter Bichsel incluso nella raccolta Kindergeschichten, di cui The White Review ha pubblicato “A Table is a Table”, la traduzione inglese della favolosa Lydia Davis. La casa in cui viviamo è il nostro territorio, ma i nomi che diamo agli oggetti che spesso si trovano in una casa sono condivisi da una data comunità linguistica: un letto è un letto, un tavolo è un tavolo. Che cosa succede alla quotidianità di una persona che decide che il tavolo si chiama tappeto e il letto si chiama quadro? Quanto si può essere radicali nel plasmare le lingue, e dunque i luoghi, a nostra immagine? Questo è un racconto che lascia il segno nella sua apparente ingenuità.
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien di Georges Perec, tradotto in italiano come Tentativo di esaurimento di un luogo parigino e pubblicato da Voland. Perec fa un esperimento: sceglie una piazza parigina, si siede ai tavoli dei cafés e annota quello che vede. “Mon propos dans les pages qui suivent a (…) été de décrire (…) ce qui se passe quando il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages“, scrive. Dato che ho scovato questo libretto mentre la newsletter era in cantiere, più che letto direi che l’ho studiato. Le domande che ancora mi saltano in testa sono: se scrivo in francese di quello che succede, o meglio che non succede, per dirla come Perec, in una nota piazza parigina, che cosa ne fa un racconto di Parigi e non il rendiconto della vita che scorre in una qualunque altra piazza di città? Le marche delle auto che passano per strada? L’abbigliamento di chi cammina? E che succederebbe se facessi lo stesso esperimento senza essere del posto, magari scrivendo anche in una lingua straniera? Come trascriverei il mio sguardo? Sto seriamente considerando l’idea di replicare l’esperimento in chiave zurighese.





“I luoghi delle nostre vite sono ciò che noi ne facciamo attraverso le storie che ci raccontiamo e che raccontiamo.” Che bella l’idea che siamo noi a creare la nostra geografia dell’anima anche solo nominando I luoghi che abitiamo.
Grazie Gaia, mi hai aperto un sacco di finestre! E che voglia di vedere "Translations", di cui sono riuscito a trovare però online una breve presentazione video.